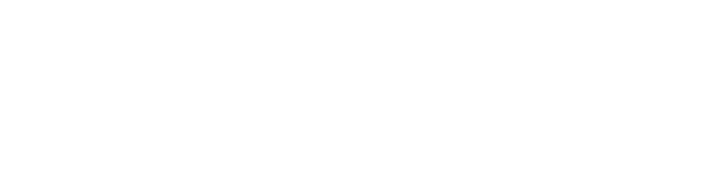Roma non è soltanto “l’antica Roma”, quella degli imperatori e dei templi pagani. Roma è anche una città dove il fascino delle rovine antiche si mescola con il caos moderno del traffico e dei locali. Questa è la Roma de La dolce vita, film del 1960 diretto da Federico Fellini. La pellicola, prodotta da Angelo Rizzoli e Giuseppe Amato ebbe una elaborazione travagliata, ma quando uscì nelle sale il cinema italiano non fu più lo stesso.
Il titolo La dolce vita è profondamente ironico. Perché non si riferisce a un’esistenza davvero serena e appagata. È la “dolcezza” superficiale della mondanità romana, fatta di eccessi, apparenze e ricerca ossessiva del piacere. Una vita malinconica, che nasconde un vuoto esistenziale e una profonda disillusione
Il protagonista de La dolce vita è Marcello Rubini, interpretato da Marcello Mastroianni, giornalista di cronaca e gossip. Un uomo diviso tra l’aspirazione alla letteratura e l’attrazione per l’ambiente scintillante ma fugace della Roma notturna. Il suo peregrinare nella capitale è scandito da incontri, feste, scandali e momenti di struggente malinconia.
Marcello vive in un mondo a metà. Da un lato, la società che frequenta per lavoro, fatta di feste sfarzose, star del cinema, nobili decaduti, intellettuali annoiati e paparazzi. Dall’altro, c’è il sogno di elevarsi e diventare scrittore, di avere una stabilità e una famiglia con la fidanzata, Emma, interpretata da Yvonne Furneaux, la cui gelosia gli appare però come una prigione.
Marcello è quindi sempre in lotta con sé stesso, al tempo stesso affascinato e nauseato, attratto e respinto, sempre in fuga da sé. La sua vita diventa la metafora della crisi dell’identità contemporanea, dell’incapacità di trovare un senso nella frenesia della modernità.
In verità, protagonista indiscussa de La dolce vita è Roma. Fin dalla prima scena, quando due elicotteri sorvolano Roma, partendo dal Parco degli Acquedotti (viene inquadrato l’acquedotto Claudio) per arrivare a Piazza San Pietro. Durante il volo, gli elicotteri passano sopra il quartiere EUR, che negli anni ’50-’60 era in costruzione.
La scelta non è casuale: l’EUR venne progettato negli anni ’30 come sede dell’Esposizione Universale del 1942 (mai realizzata a causa della Seconda Guerra Mondiale), ma completata molto più tardi, come quartiere moderno, dalle architetture razionaliste e geometriche. È il simbolo di una Roma che guarda al futuro, ma che ha perso il contatto con le sue radici più profonde.
La Roma de La dolce vita è una città variegata e multiculturale, che accoglie tutti, ma che sembra vivere di illusioni. Via Veneto, la strada del jet set, dei caffè all’aperto e dei paparazzi in agguato, è il cuore pulsante di questo mondo effimero. È una Roma che attrae e respinge, che seduce con la sua vitalità ma lascia un retrogusto amaro di disincanto. È una città notturna e brillante, che abbaglia ma non riscalda. Chi vi abita sembra non trovare pace né scopo, e soccombe alla noia esistenziale.
I personaggi de La dolce vita sono persone che fanno parte di una società in trasformazione: sedotta dalla ricchezza, dal successo e dalla fama. Come la nobile Irene, che nella festa ambientata a Palazzo Giustiniani-Odescalchi a Bassano Romano (provincia di Viterbo), si augura di finire sulle cronache scandalistiche.
E poi c’è Sylvia, l’attrice svedese che giunge a Roma perché scritturata per un film. La bellissima attrice, interpretata da Anita Ekberg, sembra far perdere la testa a Marcello. Indimenticabile la scena nella Fontana di Trevi, divenuta un’icona pop. Ma anche questo incontro si rivela una breve parentesi all’interno di una vita colma d’inquietudine.
Persino il padre di Marcello, interpretato da Annibale Ninchi, è affascinato dalla vitalità di Roma. Anche lui sembra essere sedotto dalla “dolce vita”, ma dopo un malore si riprende e decide di andarsene, nonostante suo figlio gli chieda di rimanere. Il padre di Marcello fugge dalla casa di una giovane ballerina e da Roma, per tornare a Cesena e da sua moglie.
L’incontro con Enrico Steiner, interpretato da Alain Cuny, sembra dare speranza. L’amico, intellettuale colto e a prima vista realizzato, offre a Marcello un modello alternativo di vita. Ma anche questo si rivelerà tragicamente fallace. E così, Marcello si smarrisce in un crescendo di disincanto.
Nel finale infatti, Marcello rifiuta il richiamo di Paola, una giovane ragazza già conosciuta in una trattoria, interpretata da Valeria Ciangottini. Dopo una notte passata ad una noiosa festa in casa di amici, sulla spiaggia Marcello re-incontra Paola, forse simbolo di purezza e di una possibilità di redenzione. Ma non la sente, o finge di non sentirla. È troppo distante, ormai troppo immerso nella “dolce vita”, divenuta amara.
Marcello Rubini è il ritratto di una generazione in crisi: quella moderna, divisa tra il desiderio di autenticità e il fascino dell’apparenza. Il simbolo di un’epoca in bilico tra edonismo e vuoto esistenziale.
Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli e Brunello Rondi hanno scritto una sceneggiatura complessa: sette episodi che raccontano diversi momenti della vita di Marcello Rubini. La dolce vita sfida le convenzioni narrative e rompe con il realismo per abbracciare un’estetica visionaria e surreale.
La dolce vita segnò una svolta nella carriera del regista, Fellini, divenuto uno dei più famosi del mondo. Inoltre, aprì un nuovo capitolo nella storia del cinema, consacrando il neorealismo al mito e l’Italia del boom economico all’immaginario collettivo.
Oltre a ciò, La dolce vita ebbe il merito di coniare un neologismo. Il termine paparazzo, usato per indicare un fotoreporter indiscreto e invadente, ha origine dal cognome di uno dei personaggi della pellicola. Si tratta di uno dei tanti fotografi che affollano le scene del film, e che in alcuni casi mostrano un assoluta mancanza di rispetto per la vita e i sentimenti altrui.
La dolce vita ha anche ispirato il nome di un capo di abbigliamento: il maglione a collo alto, conosciuto come “dolce vita”, proprio in riferimento al modello usato da Marcello Mastroianni nella pellicola.
Fellini trasse numerose ispirazioni dai reportage del fotografo romano Tazio Secchiaroli, al quale si deve il personaggio di Paparazzo. La scena del “falso miracolo” si basa su un servizio realizzato proprio da Secchiaroli nel 1958. Il reportage raccontava la vicenda di due bambini, di una località vicino Terni, che dicevano di vedere la Madonna. Secchiaroli, che partecipò alle riprese di quella scena, affermò che Fellini aveva saputo ricreare fedelmente la situazione a cui lui aveva assistito.
Proprio per quella scena, Fellini si è spostato nelle campagne ai margini della città. Uno spazio affollato da persone speranzose e ingannate, una Roma popolare e ingenua, in contrasto con il cinismo dell’élite cittadina. È un luogo carico di simbolismo religioso e sociale, in cui l’autenticità si mescola con la spettacolarizzazione della televisione e del giornalismo.
La dolce vita è stato girato quasi interamente a Cinecittà, comprese le scene su Via Vittorio e la salita sulla cupola della Basilica di San Pietro, ricostruite nel Teatro 5. Altri set furono il quartiere Tor de’ Schiavi, i già citati EUR (compresi i sotterranei del Palazzo dei Congressi) e Bassano Romano (allora Bassano di Sutri, come viene chiamata nel film), Bagni di Tivoli, Fregene e Passoscuro.
La dolce vita fu accolto da scandali e polemiche, ma fu osannato dalla critica e riuscì in quindici giorni a pareggiare gli 800 milioni dei costi di produzione. Il film vinse la Palma d’Oro a Cannes e un Oscar (ai costumi). Ma soprattutto, La dolce vita segnò un punto di non ritorno: il cinema d’autore poteva essere spettacolo, arte, denuncia sociale e poesia allo stesso tempo.
Nel film si mostra una vita fatta di agi, piaceri, mondanità e libertà, solo apparentemente dolce. Una vita che ha dei lati oscuri: le illusioni e il vuoto, che spesso si celano dietro il fascino della ricchezza e della celebrità. Ne La dolce vita, Fellini ci racconta una società in cui il benessere materiale non corrisponde a una reale felicità. Non solo, essa nasconde una profonda insoddisfazione, una deriva morale e una crisi di valori.
A me invece Roma piace moltissimo, è una specie di giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene.
Nel 2020 La dolce vita ha compiuto sessant’anni, ma il suo messaggio è forse ancor più attuale. In un’epoca dominata dai social media e dall’apparenza, il muto grido di Paola risuona con forza: cosa resta, alla fine, di questa “dolce vita”?