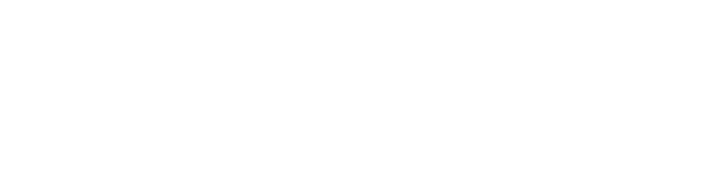Le fiere in Sicilia, un tempo, rappresentavano molto più di semplici mercati: erano veri e propri eventi collettivi, occasioni di festa e di socialità che scandivano il ritmo della vita rurale, che accompagnavano le nostre comunità da maggio fino all’autunno inoltrato. La gente non vi andava solo per comprare o vendere, ma per incontrarsi, per ritrovarsi con amici e conoscenti che arrivavano da ogni angolo dell’isola.
Ogni paese, aveva i suoi due giorni in cui la vita quotidiana si interrompeva per dare vita a momenti di festività. Ogni comunità tesseva i suoi sogni intorno a una fiera, un vortice di suoni, colori e profumi che rimane indelebile in noi. Siamo cresciuti con quei momenti: storie sussurrate tra le bancarelle, risate che echeggiano ancora tra le vie, volti di amici e conoscenti.
Insomma, siamo un mosaico vivente di aneddoti, uniti da un filo invisibile che ci lega per sempre alla fiera del nostro paese. È la radice che ci tiene saldi, un rifugio di memoria in cui le emozioni si fanno più intense e i volti amati ritornano. Ognuno ha la sua fiera legata ai propri ricordi, risate, delusioni, aspettative, insomma, col tempo è diventata tua.
Un tempo le fiere erano il cuore pulsante della vita contadina, un giorno in cui il tempo sembrava fermarsi.Ogni fiera era attesa con trepidazione, perché non solo offriva opportunità di scambio e commercio, ma costituiva anche un’occasione di rafforzare la socialità. Per molte famiglie contadine, isolate geograficamente e culturalmente, la fiera era uno dei pochi momenti di contatto con il mondo esterno.
L’elemento pulsante di queste fiere era senza dubbio l’attività agricola. Si potevano acquistare o vendere animali di ogni genere: mucche, pecore, capre, cavalli, maiali, galline, muli e asini, fondamentali per la sopravvivenza e il sostentamento delle famiglie. Accanto a questi, venivano venduti strumenti indispensabili per il lavoro nei campi — falci, zappe, corde, secchi, aratri — ma anche coperte, stoviglie, utensili per la casa e, per i bambini, semplici giocattoli di legno o latta.
Ogni ragazzo aveva il suo bel salvadanaio di terracotta che usava per conservare per mesi le poche monete guadagnate, rotti appositamente il giorno della fiera. Era un gesto rituale, quasi solenne, che sottolineava l’importanza dell’evento: si trattava spesso dell’unica vera occasione annuale per fare acquisti importanti.
Le fiere agricole erano le più frequentate e rappresentavano il momento culminante della stagione. Le comunità rurali, spesso isolate, non avevano facile accesso a questi beni. Perciò, le fiere erano indispensabili.
La fiera era anche occasione per animare i territori limitrofi. La partecipazione era garantita dalle trazzere — antichi sentieri sterrati che attraversavano l’entroterra siciliano. Fin dalle prime luci dell’alba l’animazione era assicurata dall’attraversamento di mandrie, condotte a piedi dai pastori verso i luoghi prestabiliti, spesso piazze polverose alla periferia dei centri abitati, allestite per l’occasione da autorità locali. Questi tragitti, sebbene necessari, non erano privi di pericoli: incidenti, animali smarriti, o addirittura imboscate da parte di briganti.
La fiera era anche un evento sociale e culturale. Accanto agli scambi commerciali, c’erano momenti di svago: cantastorie, musicanti, giocolieri, venditori ambulanti di dolci e noccioline. In un mondo scandito dai ritmi lenti e faticosi della terra, la fiera era una festa per gli occhi, per le orecchie e per lo spirito. Nella mia fiera, quella personale, era anche l’occasione per mangiare la prima fetta di anguria.
Quella di San Bartolomeo era la mia fiera personale e, secondariamente, della comunità di Chiusa Sclafani. La fiera era sempre rigurgitante di grandi armenti e numerosi greggi. Ogni gruppo aveva il suo posto stabilito: c’era anche un brulicare ed un vocio di uomini, muggiti, nitriti e belati risuonavano nell’aria.
La gente vi affluiva tempestivamente per pigliar posto, sicché, durante la notte, si sentiva un passare continuo di mandrie e il suono dei campanacci che portano sul collo le bestie. Una volta che si pigliava posto, nessun si rischiava, anche il giorno dopo, a cambiarlo, perché i compratori potevano avere segnalato un animale, e sapevano così dove trovarlo.
Era festa per tutti: i ragazzi del paese accorrevano all’insolito spettacolo e la gente godeva per la sfilata di tante mandrie e greggi. Le contrattazioni di compra-vendita si facevano non senza l’aiuto dei mediatori “mizzani” i quali per avere una percentuale sul negozio usano ogni eloquenza: vantavano l’animale al compratore, facevano notare invece i difetti al venditore (e questo sempre in confidenza); si dichiaravano amici ora dell’uno ora dell’altro. Era una vera commedia a lieto fine.
In paese intanto si svolge una festa popolare. Baracche con dolci e i più svariati oggetti: terraglia, rame, alluminio, letti; e qualche giostra occupa la piazza del castello. Si improntano osterie per i forestieri.
La fiera di San Bartolomeo era anche l’occasione per rinnovare i contratti degli annalora (forza bracciantile) avrebbero rinnovato il contratto con i suvrastanti o i camperi (Uomini di fiducia dei proprietari) o direttamente con i padroni. Era anche l’occasione per i proprietari di trovare nuovi annalori che cercavano di addugarsi (di farsi ingaggiare). La richiesta all’annaloro, se restava a servizio o intendeva andare via, veniva detta riquedere (rivedere il proprio contratto). Questa operazione veniva eseguita in fiera, tenendo conto dei prezzi che si venivano a definire per il nuovo anno ed era una vera e propria contrattazione.
II salario era costituito da una parte in denaro e il rimanente in derrate dette carnaggi, cioè pane, frumento, olio, vino e cacio. Gli annalora erano quasi tutti analfabeti e l’accordo veniva segnato con delle ’ntacche apposte su di una ferla (ferula) che veniva tagliata per lungo, quasi a metà. Al concedente andava la parte più consistente chiamata “madre” e all’annaloro la parte più piccola detta “figlia”.
I prelievi venivano segnati unificando le due parti di ferla. La ’ntacca (incisione) veniva incisa in modo tale da essere apposta alle due parti. Dieci tumuli di frumento prelevati venivano per esempio segnati X, cinque V, ecc. Su ogni ferla c’era il nome dell’annaloro. A fine anno venivano confrontate le ’ntacche, attraverso l’unione delle due mezze taglie, quella del padrone e quella dell’ annaloro, consentendo così di riscontrare l’accordo pattuito. Un mondo che è rimasto solo nella memoria dei più anziani.
Oggi le fiere in Sicilia hanno subito una profonda trasformazione, riflettendo i cambiamenti socio-economici avvenuti nell’isola nel corso degli ultimi decenni. L’agricoltura non è più al centro della vita quotidiana, e la figura del contadino, un tempo protagonista, ha lasciato spazio a una società più urbanizzata e meno legata alla terra.
Il radicale cambiamento è evidenziato dall’assenza degli animali da lavoro presenti in fiera. Non ci sono più mandrie di mucche, pecore o asini e muli. Al loro posto, si possono trovare animali esotici, come pappagalli, conigli e porcellini d’India, usati come compagnia.
Le fiere hanno trasformato il loro spirito, mutando da centri vitali di scambio agricolo in celebrazioni di un tempo andato. Non sono più il cuore pulsante dell’economia rurale, ma un palcoscenico di ricordi dove gli oggetti acquistati, che siano per la casa, per l’equitazione o semplici suppellettili, sono diventati testimoni silenziosi di una storia. Anche i vecchi attrezzi agricoli, ormai diventati trofei, non servono più per lavorare la terra, ma per adornare le nostre case e raccontare, con il loro solo aspetto, storie di vita, di fatica e di eredità. In questo modo, la fiera è diventata un luogo dove il passato si incontra con il presente, dove la nostalgia si fa materia e la memoria un oggetto tangibile. È un segno di una popolazione che ha perso l’identità e il legame profondo con il mondo rurale e con l’agricoltura e che vuole recuperare attraverso il ricordo che un tempo rappresentava il fondamento della sua esistenza.
Un tempo specchio fedele dell’anima di una comunità, la fiera ha mutato la sua essenza, diventando un palcoscenico di un passato che non c’è più. Non più cuore pulsante di un’identità condivisa, ma un tentativo di socialità che si nutre di echi lontani e ricordi sbiaditi. È un teatro effimero in cui attori, pubblico e oggetti si fondono in una rappresentazione artificiale, il cui unico scopo è quello di riportare in vita, anche solo per un giorno, un mondo che esiste ormai solo nella memoria. La fiera non celebra più il presente, ma onora un’eredità, una storia che continua a vivere attraverso il desiderio di ricrearla.
Nonostante questa metamorfosi, le fiere mantengono ancora una valenza sociale. Rimangono luoghi di incontro, di passeggio, di riscoperta — seppur parziale — delle tradizioni. Spesso, all’interno delle fiere moderne si riserva uno spazio alla memoria, con esposizioni di attrezzi antichi, dimostrazioni di mestieri scomparsi, o piccoli musei allestiti per ricordare un mondo che sembra lontano, ma che ha gettato le basi della cultura siciliana odierna. Restano pezzi da museo le scale di legno che riempivano angoli di piazze orami sostituite da attrezzature telescopiche più sicure e affidabili.
La fiera siciliana ha cambiato volto, ma continua a vivere. Non è più il cuore economico della comunità, ma resta un simbolo identitario, un ponte tra il passato rurale e il presente urbano. Oggi, partecipare a una fiera non significa più acquistare un bue o un aratro, ma può ancora voler dire condividere uno spazio comune, ritrovare vecchi amici, riscoprire il gusto delle cose semplici che un tempo hanno fatto parte della nostra vita. Potremmo dire che quei semplici suppellettili tengono viva la nostra memoria e i nostri ricordi.
Il cuore della fiera batte ancora al ritmo dei sapori, ma anche in questo, il passato si mescola al presente. L’irresistibile richiamo del pane con salsiccia, delle panelle e delle crocchè resiste, ma il loro gusto genuino è spesso offuscato da salse industriali, ma comunque anche questi hanno perso il loro sapore originario. Per fortuna, il profumo agrodolce, indispensabile a segnare la festa, continua a pervadere l’aria, donando alle piazze quel tocco di ruralità autentica che resiste al tempo.
Odore che si mescola con quello prodotto dai tirrunara che portano avanti con orgoglio e fatica la tradizione della preparazione della cubaita, una dolcezza croccante che racconta storie antiche d’origine esotica. E poi c’è il gelato di campagna, che ha perso la sua vivace colorazione per ritrovare il sapore puro della semplicità, un sapore che evoca ricordi di un’altra epoca. Mentre la calia e simenza resiste grazie ai temerari del gusto, visti con diffidenza dai Z-generation e i Millennials assoggettati a spritz e coca cola. In questo connubio di sapori, la fiera vive la sua trasformazione, un ponte tra il gusto del passato e le abitudini del presente.
In un mondo sempre più veloce e disconnesso dalle sue radici, le fiere siciliane rappresentano un’occasione per fermarsi, guardarsi attorno e ricordare che la storia di un popolo passa anche dai suoi mercati, dai suoi riti collettivi, dai suoi giorni di festa.